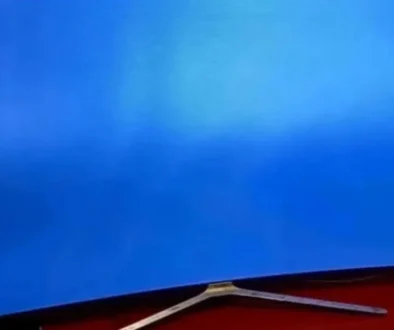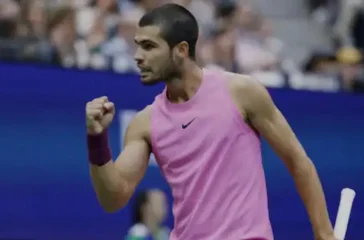8 Settembre 1943, l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati anglo amercani
L’armistizio 8 settembre 1943.
L’otto settembre del 1943 venne annunciato pubblicamente l’armistizio tra l’Italia e gli alleti, firmato il 3 settembre a Cassibile, in Sicilia. L’annuncio fu dato alle 19:42 dal Maresciallo Badoglio tramite la radio italiana: “Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate angloamericane”, dopo che la notizia era stata resa nota da Radio Algeri. L’armistizio segnò la fine dell’alleanza con la Germania, la fuga del Re e del governo da Roma, il crollo dell’esercito italiano, l‘occupazione tedesca, l’inizio della Resistenza e della guerra di liberazione. Il generale Eisenhower diede la notizia al mondo il pomeriggio dell’otto settembre alle ore 17:30 italiane. Nella notte tra l’otto e il 9 settembre, il Re e il suo governo fuggirono da Roma per rifugiarsi nel Sud Italia, allora occupato dagli Alleati.
A causa della fuga del Re e del governo, l’esercito italiano rimasto privo di ordini precisi e lasciato senza comandi, si sfasciò, centinaia di migliaia di soldati furono fatti prigionieri dai tedeschi. L’otto settembre segnò la data d’inizio della Resistenza italiana, di conseguenza iniziarono i primi scontri tra civili, militari italiani e le truppe tedesche, scontri che portarono alla battaglia di Porta San Paolo a Roma. L’annuncio dell’armistizio e la successiva occupazione tedesca portarono alla divisione dell’Italia in due: il Regno del Sud, controllato dal Re e sotto la tutela alleata, e la Repubblica Sociale Italiana, uno Stato “fantoccio” creato da Mussolini nel Centro-Nord Italia.
I motivi dell’l’armistizio e la conseguente resa si devono ricercare nella grave crisi militare, politica, economica e sociale che attraversò l’Italia dal 1942 e nel fallimento della “guerra parallela” al fianco della Germania nazista. Svanita l’illusione di una guerra breve e facile, gli insuccessi delle forze dell’Asse sui vari fronti di guerra fecero crescere l’ostilità alla guerra in gran parte del popolo italiano. Il crollo del fronte italiano in Russia nel gennaio 1943, la resa delle forze dell’Asse in Tunisia nel maggio dello stesso anno, lo sbarco alleato in Sicilia il 10 luglio 1943 aggravarono la crisi politica del regime fascista, che raggiunse il suo apice con l’arresto di Benito Mussolini il 25 luglio e la sua sostituzione con l’anziano Maresciallo Pietro Badoglio.
L’armistizio 8 settembre 1943
Nei 45 giorni trascorsi tra la deposizione di Mussolini e l’annuncio dell’armistizio il governo italiano si trovò ad affrontare un difficile compito:gestire sul fronte internoil crollo del fascismoe proseguire la guerrasal fianco della Germania. La dura repressione interna che si verificò anziché favorire l’unità nazionale, rafforzò le divisioni della società italiana. La politica badogliana fu caratterizzata da molte ambiguità: nei confronti dell’alleato tedesco, con richieste di rinforzi e assicurazioni della propria fedeltà all’Asse; nei confronti degli angloamericani con segnali contraddittori sulle proprie intenzioni e nei confronti dei partiti democratici e antifascisti che spingevano per ribaltare il tavolo delle alleanze e porre fine senza remore alla guerra.
Il crollo del fascismo fu percepito in Germania come un grande allarme. Hitler, convinto che la capitolazione fosse ormai imminente, ordinò l’elaborazione di dettagliati piani di occupazione e il trasferimento in Italia di consistenti forze militari. Nella percezione tedesca, la difesa della Sicilia dipendeva ormai soltanto dalla Wehrmacht, mentre le forze italiane si erano in gran parte sbandate. Ovunque nei territori occupati dai due paesi, gli ufficiali e i funzionari italiani avevano da tempo iniziato a prendere le distanze dai tedeschi. Hitler nutriva una forte avversione nei confronti della casa regnante e delle alte gerarchie militari italiane. Le notizie di disordini politici erano allarmanti e la ripresa delle attività delle forze antifasciste e democratiche, non più illegali, veniva vista come avvisaglie del bolscevismo. Era impensabile per Hitler che il crollo del regime fascista avvenisse senza colpo ferire. Agli occhi dei vertici del Reich, solo il fascismo e la persona di Benito Mussolini erano garanzia di affidabilità. Il sostegno dato dalla Germania a un regime screditato come quello fascista nell’estate 1943 divenne una pesante ipoteca per il futuro dei due paesi.
Le circostanze che portarono all’armistizio fornirono alla dirigenza nazionalsocialista un motivo propagandistico potente e efficace, quello del presunto “tradimento” italiano, i cui responsabili erano non solamente i vertici militari ma anche l’intero popolo italiano. La condanna del “tradimento” divenne parte integrante dell’esperienza soggettiva dei militari della Wehrmacht e di esponenti del Terzo Reich. Stereotipi negativi venivano estesi e attribuiti all’intero popolo, accusato di inaffidabilità, oziosità e opportunismo, caratteristiche queste che, plasmate dalla visione ideologica e razziale nazista, venivano ritenute essere un carattere distintivo e intrinseco degli italiani.
Le memorie, i diari e le lettere scritte da soldati e ufficiali in Italia contengono numerosi riferimenti alle sensazioni e alle reazioni personali e della popolazione italiana all’annuncio dell’armistizio definito con termini vari: Schweinerei (porcheria), Badoglio-Verrat (tradimento di Badoglio) con toni spesso di incredulità, stupore, ma anche con giudizi fortemente negativi nei confronti del popolo e dei militari italiani.

Giornalista, Libero Professionista, rugbista.